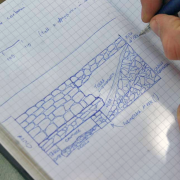L’archeologia NON è un mistero
Una delle mie occupazioni principali quando navigo online è monitorare le notizie a tema archeologico: che si tratti di scoperte, nuove aperture o convegni mi interessa studiare il modo in cui l’archeologia viene comunicata sui giornali, siano essi cartacei o web.
Da questo monitoraggio è scaturito anche il ppt che ho presentato nel corso di un incontro a La Sapienza che ha visto insieme archeologi e antropologi per raccontare la figura dell’archeologo a tutto tondo, sia nella sua percezione all’esterno che nella sua percezione all’interno della categoria.
Qui trovate le slide dell’intervento.
Tutto questo per dire che il tema della rappresentazione (e anche dell’auto rappresentazione) dell’archeologia sui media, tradizionali e non, occupa spesso i miei pensieri.
Oggi quindi voglio parlarvi di cosa NON è l’archeologia per noi archeologi e di cosa invece È l’archeologia per i non archeologi.
Prendo spunto da tre fatti:
- Sfogliando alcune brochure di festival cinematografici a tema archeologico mi sono imbattuta spesso in film e documentari i cui titoli contengono le parole “misterioso” e “tesori”;
- Qualche giorno fa un articolo uscito su Il Messaggero titolava “Misteriosa piramide etrusca a Bomarzo: è nascosta da secoli nei boschi della Tuscia”
- Alcune settimane fa un altro articolo uscito su La Repubblica di Bari titolava invece “Bari, un’antica necropoli scoperta per caso a Ceglie del Campo” e la prima frase recitava “Un tesoro archeologico nel sottosuolo di Ceglie del Campo”
Ora.
Se io non fossi un’archeologa e mi trovassi a leggere questi articoli o titoli cosa penserei secondo voi?
Che gli archeologi trovano tesori misteriosi e nascosti, per caso.
Eppure in quasi 10 anni di formazione accademica non mi è mai capitato di leggere la parola “mistero” su uno qualsiasi delle decine di libri di testo studiati e allo stesso modo non mi è mai passato per la mente di definire “tesoro” un rinvenimento, per unico e prezioso che possa essere (e alcuni oggetti di pregio li ho visti nei miei anni di lavoro).
Per non parlare del fatto che nelle aule universitarie ore e ore di lezione sono dedicate alla fase pre-scavo intesa come raccolta di documenti, fonti, informazioni, in grado di indirizzare la ricerca. Chiedetelo a un topografo se i risultati delle indagini sul campo vengono fuori “per caso”!
Come è possibile allora che si crei questo corto circuito comunicativo in cui l’archeologia viene descritta come un qualcosa che assolutamente non corrisponde alla realtà?
Qui non parliamo di verosimiglianza tra realtà e rappresentazione, di una professione cioè che ha qualcosa di misterioso o inconoscibile o inintelleggibile e quindi può essere facilmente fraintesa. Tutt’altro!
Un archeologo sa esattamente qual è il suo lavoro, sa per esempio che:
- I rinvenimenti non avvengono per caso.
- Non esiste il mistero, ma esistono domande alle quali la ricerca prova a dare delle risposte.
- Non ci sono tesori, ma contesti di rinvenimento.
E soprattutto noi tutti sappiamo che l’archeologo del XXI secolo si è finalmente liberato dalla patina romantica dell’ esploratore ottocentesco che partiva verso posti esotici alla scoperta di antiche civiltà (saccheggiandole in gran parte dei casi, non essendo stato ancora codificato il metodo stratigrafico) e che oggi è più vicino ad uno scienziato che a Indiana Jones.
Io vi farei parlare con chi studia le sezioni sottili, con chi si occupa di archeometria, con chi lavora sul Gis o con chi, chiuso nei magazzini, classifica cassette e cassette di ceramica, per farvi passare la voglia di parlare di misteri e tesori.
Perché questi professionisti sarebbero in grado di spiegarvi che dietro la parola archeologia si nasconde un tesoro (adesso sì) di competenze specialistiche acquisite in anni di studio e che quando scrivete la parola mistero state soprassedendo su tutte queste competenze dando credito ad una visione distorta e caricaturale dell’archeologia. Allo stesso modo che se definiste sciamano un medico.
È chiaro che in un articolo giornalistico non si può scrivere “la forma Hayes 50 ha datato l’US 378”, ma è altrettanto chiaro che se si continua a diffondere l’idea che gli archeologi siano scopritori di tesori misteriosi, al prossimo passante che fuori dalla recinzione del cantiere dove stiamo sorvegliando la posa della fogna ci chiederà “quali tesori avete trovato” non ci resterà che rispondere “un beneamato cippo”.
Articolo che lancia la campagna – like + archeologia
Antonia Falcone
(@antoniafalcone)