Vita da archeologi: la mia esperienza ~ di Caterina Ottomano
Vi presentiamo oggi con grande piacere il post inviatoci da Caterina Ottomano, tra le prime ad essere entrata in contatto con Professione Archeologo e ad averci dato il suo sostegno.
In questo articolo troverete condensata la sua particolarissima esperienza di vita, che fornisce interessanti spunti di riflessione a tutti noi.
Caterina ci interroga su una questione cruciale del nostro percorso formativo e professionale: essere e fare gli archeologi può essere un mestiere duraturo o rappresenta un intervallo che presto lascia il posto alla necessità di avere un lavoro vero? Può l’archeologia diventare una vera professione?
Grazie Caterina!
.
Quando mi sono iscritta a Scienze della Terra a Milano non avevo la benché minima intenzione di occuparmi di archeologia, certo mi interessava molto la storia, ma la cosa finiva lì.
La mia tesi di laurea è consistita nel rilevamento geologico dei terrazzi fluviali e fluvioglaciali del territorio a nord di Novara e nell’analisi sedimentologica dei depositi che li costituivano, si trattava quindi di geologia del Quaternario, un campo nuovo a Milano.
All’epoca, all’inizio degli anni ’80, molti laureati in geologia venivano impiegati all’AGIP, nella ricerca degli idrocarburi e anch’io pensavo di dover/poter fare la stessa fine. Però, a sparigliare le carte è arrivato in dipartimento da Reggio Emilia un giovane ricercatore: Mauro Cremaschi, quaternarista e geoarcheologo, appunto. Lui mi ha seguito sulla parte della mia tesi dedicata ai depositi eolici e poi ha proposto a me e ad altri colleghi di andare a scavare una settimana nel sito paleolitico di Isernia la Pineta, che era stato scoperto da pochi anni. L’ho fatto, ci sono andata, mi sono intossicata con il paraloid, ho vomitato per due giorni e ho giurato a me stessa che non avrei mai più scavato.
Detto fatto, dopo la laurea, nel 1986, su consiglio ed incitamento di Cremaschi ero presidente di una cooperativa di geologi litigiosi che ricordava l’armata Brancaleone e a luglio trepidante e sudata ho partecipato al primo scavo: un sito dell’età del ferro vicino ad Alessandria in mezzo al mais e alle zanzare.
Con l’autunno sono stata reclutata da una ditta di Milano – la cui socia ‘anziana’ aveva la bellezza di 32 anni – negli scavi urbani di via Moneta e lì ho conosciuto una serie di archeologi inglesi ridotti alla fame dai tagli della Tatcher e giunti in Italia perché allettati dal lavoro abbondante e dalle buone paghe.
Tenete conto che gli anni ’80 e ’90 sono stati un momento d’oro per l’archeologia per la gran quantità di opere grandi e meno grandi che si sono effettuate sia in contesto urbano che extraurbano; moltissimi archeologi si sono formati allora ed alcuni sono gli stessi, invecchiati e inaciditi, che dirigono alcune società o cooperative con cui avete a che fare. All’epoca, però, tutti erano felici, entusiasti e giovani, soprattutto.
Nel tempo, pur continuando a scavare, mi sono specializzata in archeomicromorfologia – che consiste nello studio al microscopio di suoli e terreni antropici – ed in analisi del rischio archeologico. In quanto professionista ho lavorato in ambiti di ogni genere dal paleolitico al postmedioevo, ma la maggior parte delle analisi micromorfologiche le ho eseguite su campioni provenienti da siti pre-protostorici. Ho partecipato ad alcune campagne di scavo nel Pakistan del sud con l’Università di Venezia e in Libia con l’Università di Roma La sapienza.
Il mestiere dell’archeologo, lo sapete, non è tutto rose e fiori: con gli ispettori di soprintendenza i rapporti sono sempre tesi e difficili, il professionista è spesso visto come una cazzuola attaccata ad un braccio, avida e priva di spessore scientifico; non è vero, naturalmente, alcuni miei colleghi sono ora funzionari o soprintendenti, altri lavorano in università; sono una minoranza comunque, considerando che siamo partiti in moltissimi. Non parliamo delle imprese edili con cui si ha a che fare, che ci vedono come il fumo negli occhi, che sono sempre pronte a gettare la croce dei ritardi sugli ‘scavi’ e che appena ti volti ti devastano ettari di abitato.
Che dire poi dei kilometri percorsi su macchine scassate e rumorose, di milioni di ore dormite in pensioni di infino ordine, in aule di scuole elementari, in palestre puzzolenti? E i pagamenti, che man mano che la crisi economica procedeva impiegavano più tempo ad arrivare, e giù telefonate di sollecito. Questo è un lavoro per giovani; più il tempo passava più io mi rendevo conto di essere stanca, di volere stare un po’ casa, e poi, la cosa più grave, non ce la facevo più a lavorare in cantieri di speculazione edilizia, in cui il cemento subentrava alla campagna o alle poche aree libere in città.
Nel 2003 ho tenuto un corso a contratto all’Università di Genova che ha avuto come argomento la geopedologia e la micromorfologia e agli studenti che lo frequentavano ho consigliato vivamente di intraprendere una carriera diversa o, comunque, di tenersi aperta un’altra porta. Alcuni mi hanno ascoltato.
Poi, nel 2004, dopo un mese di fila passato a non dormire, ho deciso: basta scavi, non ne posso veramente più. Ho aperto un piccolo negozio di modernariato e vintage nei vicoli di Genova, mantenendo solo l’attività di consulenza geoarcheologica. Ora mi sono spostata con l’attività in una bella strada turistica e devo dire che per fortuna ho approntato il piano B, perchè anno dopo anno, le richieste di analisi e di assistenza sono sempre meno e i pagamenti arrivano sempre più tardi o non arrivano.


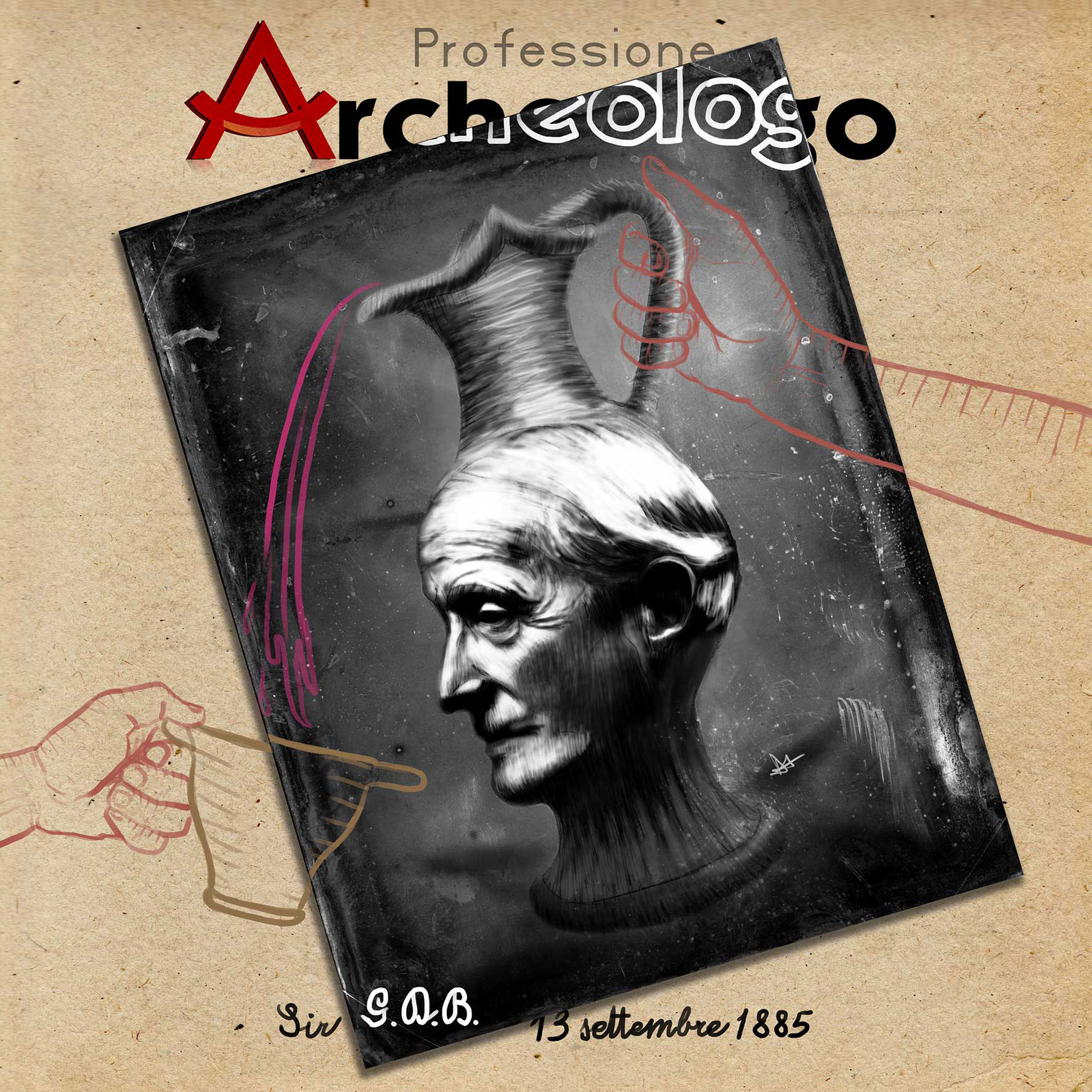
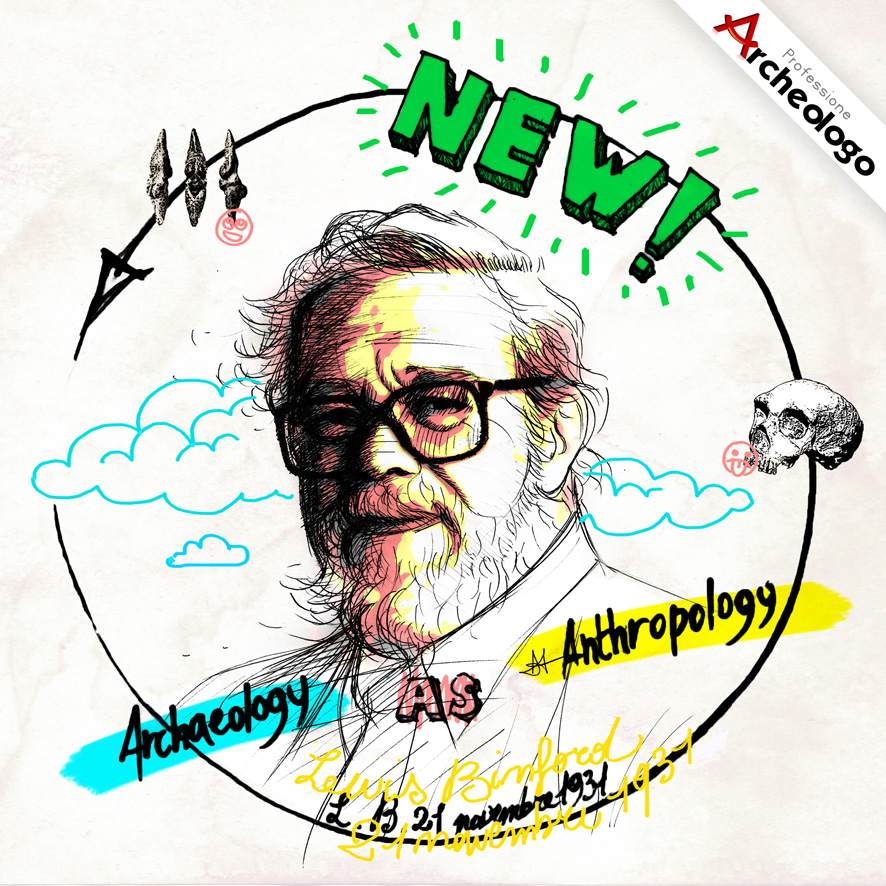






Ricordo il corso di Caterina Ottomano all’Università, anche se non lo seguii (ebbene sì, mi sono formata a Genova; e ricordo anche di averla vista una volta su un cantiere a Imperia per una consulenza. Ma non vorrei sbagliare). Ricordo anche l’idea che avevo all’epoca dei docenti universitari, incapace, io, di fare distinzione tra ordinari, associati e professori a contratto. Quello che mi sfuggiva dei professori a contratto, in particolare, era il fatto che fossero precari né più né meno dei ragazzi che prestavano le loro braccia e le loro forze su cantieri di archeologia di emergenza, assoldati al minimo sindacale da cooperative che un po’ per far quadrare i propri conti, un po’ per cieco sfruttamento, con una certa crudeltà ti facevano pendere dall’alto la decisione se prenderti o meno per il prossimo scavo… Certo, qualche voce mi giungeva, ma erano piuttosto mitologie, o pettegolezzi detti non senza una certa cattiveria, come quel tale, di cui non farò il nome, che arrotondava servendo pizze in un locale la sera, ma che durante il giorno se la spacciava da grande archeologo…
Leggere il post di Caterina Ottomano (per me rimane comunque la docente che ho incrociato sulle scale in università in via Balbi) mi ha messo davanti agli occhi una triste verità. Già i suoi tweet disillusi mi avevano messo sulla buona strada, ma il suo post è una conferma: in Italia non c’è posto, per sempre, per un giovane ed entusiasta archeologo che voglia fare l’archeologo anche da grande. Effettivamente siamo in pochi. Io mi continuo pervicacemente a definire archeologa, ma di fatto faccio la custode, sicché siamo sulla stessa barca.
L’importante è che non ci sia rimpianto. Rabbia sì, quella ci può essere. Perché non è colpa di Caterina se ha deciso di mollare. Non è dipeso da lei. è dipeso da una situazione lavorativa che in realtà non esiste, perché l’archeologo come professione non esiste, non ha regole, le uniche regole che ha gli vengono dagli stimoli che la sua stessa vita gli dà. E per una donna, non ve lo devo dire io, c’è più di uno stimolo a dire di mollare tutto.
Purtroppo la situazione fotografata da Caterina negli anni non è cambiata: lei è uscita dal “mercato” archeologico nel 2004, io vi sono entrata a fine 2005, e la situazione non è per nulla diversa. E non lo nego: nonostante il mio lavoro non mi piaccia, so perfettamente che non avrei potuto reggere la vita dell’archeologo da cantiere urbano: né fisicamente né economicamente, per non parlare del fatto che non si può campare saltando da un contratto all’altro, da una cooperativa all’altra, in giro per l’Italia, una volta per un mese, una volta per 2 settimane, spesso senza sapere cosa farai il giorno dopo: a 30 anni, una donna (ma anche un uomo!) vuole essere in condizioni di crearsi una famiglia! Dubito che avrei continuato a fare l’archeologa da campo, per quanto la terra e lo scavo mi manchino. Non mi mancano le condizioni disagevoli in senso fisico, mentale, economico e sociale, quelle no. Perciò mi tengo ben stretto il mio posto da custode, e ringrazio il cielo di aver vinto quel benedetto/maledetto concorso.
Ciao Marina. Io credo che tu abbia fatto bene ad accettare quel posto di custode, anche altri colleghi, più anziani di te, hanno preso la stessa decisione, seppur con rammarico. Però uno stipendio è uno stipendio, e considerando che molti funzionari presto andranno in pensione, potrebbero esserci possibilità di concorsi interni per i custodi leureati e specializzati/dottorati. Mi rendo conto che come mestiere il vostro non è un granch’è e probabilmente anche i rapporti con i superiori sono quel che sono; pensa che una mia amica, archeologa con grande esperienza e novella custode, è stata impiegata a Genova come segretaria del soprintendente. Della serie, sfruttiamo al meglio le professionalità.