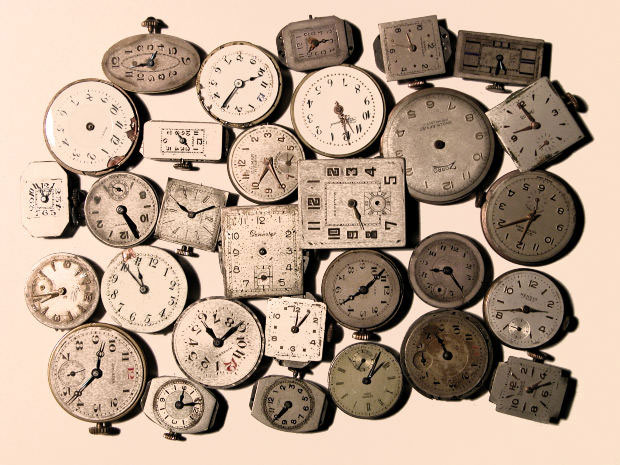Di piramidi, tirocini e tweet: beni culturali e la politica dello spot
Sono strani questi giorni tra maggio e giugno per i beni culturali italiani, strani e pieni di notizie e annunci.
Provo a fare un riassunto e a proporre qualche riflessione.
Il 26 maggio viene inaugurata la mostra “Pompei e l’Europa. 1748-1943”, articolata in due sedi, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e agli scavi di Pompei, e per la quale è stato creato un apposito (e non particolarmente bello, ma questi son gusti personali) sito internet, nonostante la Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia abbia già un bel portale ricco di notizie e approfondimenti. A Pompei la sede scelta è l’anfiteatro, dove più o meno dalla sera alla mattina è comparsa una strana piramide che dovrebbe rappresentare il Vesuvio, ma che lascia perplessa persino la stampa inglese. All’interno, sospesi a mezz’aria su sostegni in metallo quasi fossero opere d’arte contemporanee, venti degli 86 calchi restaurati delle vittime dell’eruzione del 79 d.C., in una scelta espositiva quanto meno di dubbio gusto, figuriamoci definirne il valore storico-scientifico.
Il 30 maggio il Ministro Dario Franceschini scrive su Twitter:
Presto operativo il decreto che ho firmato oggi per 130 tirocini di 6 mesi per giovani laureati a Pompei e in musei, archivi, biblioteche.
— Dario Franceschini (@dariofrance) May 30, 2015
Pochi giorni e viene rivelato che i tirocini, finanziati dal Fondo 1000 giovani, saranno rivolti a laureati di età inferiore ai 29 anni e avranno un compenso lordo di 1000 Euro al mese, che in tempo di crisi non sono male. E poi sono sei mesi a Pompei. Come esperienza dopo la laurea, vuoi mettere?
Il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, viene ufficialmente annunciata una notizia che circolava già da qualche giorno: dal 23 giugno il Quirinale sarà aperto cinque giorni su sette e non più solo la domenica, con due percorsi di visita da prenotare online con almeno sei giorni di anticipo e la possibilità di usufruire di una guida, che sarà affidata a volontari del Touring Club e studenti de La Sapienza, anche loro volontari. Oltre a prevedere il divieto di introduzione di oggetti contundenti, zaini ingombranti e apparecchi fotografici (come la mettiamo con gli smartphone? ), le nuove regole escludono le guide abilitate, che non potranno più accompagnare gruppi di visitatori, ma entrare solo come privati cittadini. Naturalmente, la protesta, su Twitter, non si è fatta aspettare.
Lo scorso mercoledì 3 giugno, l’ANSA fa sapere che dopo i Pink Floyd saranno i ragazzi de Il Volo, fenomeno mondiale e vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, il secondo gruppo musicale ad esibirsi negli scavi Pompei, dove la prossima settimana registreranno uno speciale per la TV americana PBS, perché si sa, i luoghi comuni sull’Italia e l’italianità son duri a morire e ogni tanto è il caso di riproporli.
Lo stesso giorno, ma in serata, così c’è stato tempo di digerire meglio la prima notizia, arriva un altro annuncio via Twitter del Ministro Franceschini e per un momento, lo confesso, ho pensato (e forse sperato) che fosse il risultato di una violazione di account.
Faremo la Biblioteca Nazionale dell’Inedito. Un luogo dove raccogliere e conservare per sempre romanzi e racconti di italiani mai pubblicati
— Dario Franceschini (@dariofrance) June 4, 2015
L’ironia è davvero troppo facile, e del resto, se c’è qualcosa che noi italiani abbiamo in sovrabbondanza, è proprio quella (questa è la mia risposta preferita).
Infine venerdì (il 5 giugno), il Ministro ha fatto sapere che l’idea di cui si era molto parlato quest’autunno, quella di ricostruire l’arena del Colosseo, ispirata da Daniele Manacorda, diventerà realtà: il bando sarà internazionale e secondo le previsioni i lavori dureranno 5 anni e saranno finanziati per circa 20 milioni di euro, la gran parte dei quali fondi pubblici. Nel frattempo, quasi a dare un’assaggio di quel che verrà, è stato ricostruito e verrà presto inserito nel percorso di visita al pubblico, uno dei 28 montacarichi che trasportavano gli animali feroci nell’arena. Una bella storia di archeologia sperimentale questa, nata quasi per caso due anni fa, quando la Providence Pictures, casa di produzione americana, propose la ricostruzione del montacarichi per il documentario Colosseum-Roman death trap del regista Gary Glassman, assumendosi i costi dell’intera operazione (qui il comunicato stampa del MiBACT).
Tante notizie, insomma, in questi giorni che scivolano lentamente verso l’estate, che toccano alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano, e che, al di là dei contenuti specifici, mettono in luce, se mai ce ne fosse bisogno, che la politica culturale in Italia si fonda ormai su due linee d’azione.
Da un lato “grandi eventi spot”, su cui riversare tanti bei soldi, spesso pubblici, ma anche, sempre più di frequente, privati, il che non è affatto una cattiva notizia, almeno a mio modo di vedere, purché i termini siano chiari e si tenga presente il valore intrinseco del bene su cui si va ad intervenire. Essendo “spot”, però, tali interventi tendono spesso a riguardare pochi monumenti ben noti, assurti a simbolo del nostro paese (“il Colosseo nella sua grandiosità è simbolo non soltanto di Roma ma di tutta l’Italia”, dice Franceschini nell’annunciare il progetto dell’arena), mentre tanti luoghi storici e aree archeologiche versano nelle condizioni che tutti conosciamo. A volte, come la futura Biblioteca Nazionale degli Inediti (Sarà un luogo fisico? Dove nascerà? Chi deciderà quali libri conservarci? I miei diari di adolescente saranno accettati?) o la strana mostra dell’anfiteatro di Pompei, i risultati di certe operazioni sono talmente fuori dal mondo e dalla logica che l’unica reazione è questa qua.
La logica dei grandi eventi, è anche la logica dei grandi numeri, e così, sempre il ministro Franceschini e sempre su Twitter, sbandiera, ad esempio, “i numeri da capogiro”, dei visitatori degli scavi di Pompei, della Reggia di Caserta e del Colosseo durante l’appuntamento mensile della #DomenicalMuseo, tanto numerosi da mettere a rischio persino l’integrità stessa dei luoghi, letteralmente assaliti da migliaia di persone. Ma siamo sicuri che grandi folle siano sinonimi di “successo”? E che sia questo tipo di successo quello di cui il nostro patrimonio culturale e noi italiani abbiamo bisogno?
Dall’altro lato, e sembra quasi un controsenso ma non lo è se la logica che ti guida è lo “spot”, si punta chiaramente al risparmio sulle professionalità.
Così il volontario sostituisce il professionista e i fondi a disposizione sono usati per assunzioni anch’esse, in fondo, un po’ “spot”, perché un tirocinio di sei mesi, benché retribuito, non è lavoro, e perché con la frequenza con cui queste forme di lavoro vengono proposte esse diventano a tutti gli effetti una soluzione reiterata di reclutamento a basso costo.
Niente di nuovo sotto il sole, davvero, ma il tutto si tinge di un po’ di amarezza, se, alla fine di una nuova presentazione del libro Archeostorie (giovedì scorso a Cosenza, in una bella mattinata piena di spunti e di sano ottimismo), ti ritrovi a parlare con un piccolo gruppo di archeologi che ti rivelano di “aver mollato” o che ricordano colleghi, validi e preparati, che “non ce la facevano più”, che hanno “ripiegato” su altro e ora non fanno più gli archeologi.
Quante storie così conosciamo?
La domanda, alla fine, è sempre la stessa.
Cosa vogliamo farci, noi, con i nostri beni culturali?
Vogliamo che siano petrolio, che mette in moto e brucia e si consuma (e inquina)? Perché politica dello spot per me significa questo: è l’inseguire una visibilità che si spera si traduca in ricaduta e sviluppo economico ma che non lo farà perché dietro manca una progettualità coerente.
Oppure vogliamo che il nostro patrimonio culturale sia humus, da proteggere e conservare, sì, ma anche da studiare e conoscere, da valorizzare e grazie al quale costruire nuova cultura, nuovo sviluppo sostenibile, comunità vere radicate nel territorio?
E su cosa vogliamo puntare se non sulle persone, sulle competenze, sull’innovazione, sulla creatività, sulla loro passione?
Io la mia risposta ce l’ho, ma devo dirlo, certe volte, non è per niente facile.
domenica_pate